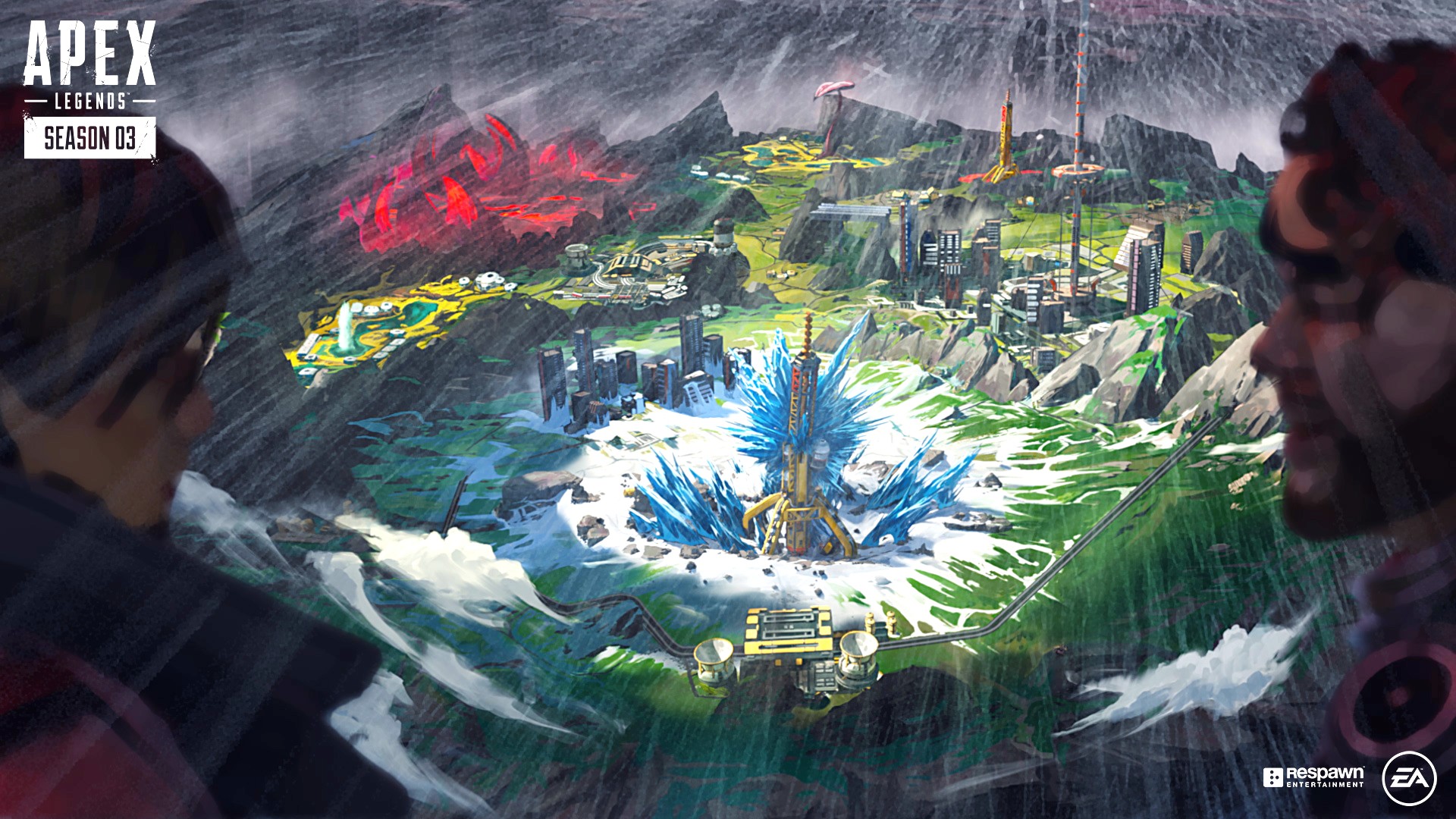Portato a termine BioShock Infinite (qui la nostra recensione), non posso certo espellere a pressione le poche ma interessanti letture inerenti a quello che ad oggi sembra non solo il miglior titolo del 2013, bensì uno dei più notevoli nel corso dell’attuale generazione. Un turbinio di recensioni tra l’entusiasta e l’incensante, tentazione alla quale la critica spesso cede quando si è davvero goduto spettacolo. Ed in fondo è bello che si sia ancora capaci di farsi trascinare fino a questo punto; pensate a quando da bambini ci si infervorava per qualcosa che ci aveva colpito particolarmente: era tutto un costante e molesto gesticolare, mentre nient’altro esisteva in quel metro quadro che si occupava con la propria persona ed in quel bel più ampio non-spazio della propria immaginazione, se non quanto si riusciva ad evocare trasognanti.
Ho scorto questo e non solo nelle molte righe alle quali, seppur un tantino distrattamente forse, mi sono dato nei giorni scorsi. Voti altisonanti, considerazioni epocali, febbre da capolavoro: su questa linea si inseriscono la stragrande maggioranza delle recensioni che potete trovare in rete. Eppure mi pare che tale e tanta euforia abbia inebriato a tal punto da non rendere giustizia ad un discorso che, in fondo, trascende il singolo titolo, quale esso sia. In parte probabilmente influenzati da quella critica alla cosiddetta Arte Contemporanea, non del tutto erroneamente parecchi redattori si sono dati ai cosiddetti giudizi viscerali, acconsentendo affinché quel ragazzino che abita in ognuno di noi avesse modo qua e là di dire la propria. Come quei bimbi a cui è meglio tenere la mano sulla bocca per evitare che si prodighi in affermazioni sconvenienti, basta togliere per un attimo quella mano perché lui, sorrisino alla bocca, elargisca a gran voce la sua sentenza. Ripeto, descrivo tutto ciò se non con accondiscendenza, quantomeno con simpatia. Ed in fondo ringrazio il cielo che ancora si sia capaci di certe cose.
Tuttavia mi pare, come già ravvisato, che sia mancato qualcosa. E badate bene, non si tratta di omissioni o dimenticanze, volontarie o meno. Grossomodo chiunque è stato in grado di evidenziare pregi e difetti di Infinite (o almeno, coloro che hanno redatto le recensioni che ha letto il sottoscritto). Quello che mi spinge a pormi talune domande è stato più che altro il soprassedere su certe cose, in virtù di un’esperienza che, nel più sobrio dei casi, viene considerata travolgente. Lungi dunque dal voler fare il guastafeste, mi pare sia il caso di cominciare a riflettere con un pizzico di serenità in più, mentre i postumi della sbornia cominciano magari a dissolversi.

DI COSA PARLIAMO
Questo significa, anzitutto, inquadrare il nostro discorso. E, ancora una volta, mi viene concessa un’ottima opportunità per tornare sul tanto caldo dibattito inerente a quale sia il rango in cui collocare il Videogioco. Esatto, proviamo a parlare di Arte, per quanto mi è concesso. Titoli come questi, a prescindere dal loro valore intrinseco, ci scaraventano a forza su questo campo speculativo, accludendo tali argomentazioni unitamente alla confezione nella quale sono contenuti: come dire, insieme al gioco compri anche che dopo ti toccherà parlare o ascoltare di dissertazioni che vanno ben oltre il giocato; e che non di rado suscitano pure un discreto mal di testa. Quest’ultima fattispecie, cercheremo di evitarla, senza false promesse però.
L’opportunità è ancora più ghiotta perché mi permette di spaziare su due delle chiavi di lettura che ho fino ad ora coltivato in relazione alla presunta ragionevolezza di tesi (tutt’altro che dimostrate) secondo cui il Videogioco sia Arte. Senza entrare troppo nel merito, sia per non tediare il lettore più di tanto, sia al fine di offrire alcuni spunti che rientrino in un discorso non troppo sfilacciato, più da manuale che da articolo di approfondimento.
Anzitutto intendo soffermarmi su una distinzione che tanti continuano quasi inspiegabilmente a non vedere, oppure a non accettare, ossia la differenza tra Arte e ciò che è artistico. Ho già avuto modo di soffermarmi, all’interno di queste mura, su tale differenza, senza però esaurire un discorso che, certamente, non troverà pace nemmeno stavolta. «Perché», diranno alcuni, «c’è davvero qualcosa di diverso tra i due termini?». Beh, direi proprio di sì, ed Infinite costituisce un esempio che mostra appieno l’operatività di tale necessaria separazione. Per semplificare l’esposizione, perdonate chi scrive se opterà per metafore o similitudini equivoche, più che altro nel senso che tendono involontariamente a banalizzare un discorso davvero molto più complesso.
Immaginate voi stessi, così per come siete, in piedi accanto a un muro. Che vi piaccia o meno, ciascuno di voi è Arte: nelle sue imperfezioni, nelle sue asperità, nelle sue invincibili miserie; siete opera di Qualcuno o Qualcosa che, ab nihilo, vi ha dato forma col suo biblico soffio. Per alcuni si tratta tutt’al più di poesia, mentre altri potranno anche sentirsi a loro agio nel quadro di simili ragionamenti. Ma qui a me non interessa mettere in discussione la fede di alcuno: fate uno sforzo e date per buono il concetto di Creazione, in questo caso solo perché funzionale a quanto intendiamo esporre. Dando quindi per pacifico che ciascuno di voi sia Arte, ci interessa anche poco, al momento, definire cosa l’Arte stessa sia. Sappiamo che voi, frutto di lavoro, di un operato, siete Arte in quanto fattura. Ebbene, come aversi qualcosa di artistico al di fuori della vostra persona, in ciò che è percepibile ed in ciò che non lo è? “Semplice”, basta un processo che per comodità possiamo definire di emanazione.
Vi ho lasciato accanto a quel muro. Bene, immaginate pure di trovarvi in un posto che sia in qualche misura illuminato. Da qualche parte, a secondo il punto da cui la luce deriva, nonché dalla sua intensità, potrete senz’altro scorgere la vostra ombra. Trattasi di un’impronta, ridotta ai minimi termini, di un’opera d’Arte. Non Arte in sé, ma artistica in quanto emanazione di una forma che è la vostra e la vostra soltanto. È dunque evidente, a chi già è riuscito ad andare oltre, che non esiste un solo grado di artisticità, ma di svariati. Sì perché un grado più perfetto di emanazione lo si può certamente avere opponendo la nostra immagine ad uno specchio: anche in quel caso, nonostante la pressoché esatta riproduzione, trattasi comunque di un surrogato, qualcosa che di per sé non è Arte. E perché non lo è? Perché, essenzialmente, senza l’opera originale non si avrebbe ombra o riflesso.
Ora, qualcuno, peraltro saggiamente, potrebbe far notare che in questo modo escluderemmo quasi ogni Arte esistente, in uno sterminio iconoclasta dal quale in realtà sempre prendo le dovute e siderali distanze. Quanto sopra riportato non va preso alla lettera; me ne sono servito per cercare di evocare un concetto che, esplicitamente o meno, ricorre di qui a breve. Vale a dire che l’Arte cammina benissimo con e sulle proprie gambe. Pur dovendosi fondare su qualcosa, non ha bisogno di ombre perché da zero la si crea non in forma di surrogato; quando c’è acquista una sua essenza, che è indipendente da tutto il resto. Ciò che è artistico, invece, necessita disperatamente di un appoggio, pena non esistere affatto; a differenza dell’Arte, non riesce a rendersi indipendente in alcun modo, né in termini di sostanza né in termini di espressione.

LINGUAGGIO O LINGUAGGI?
Ci avviciniamo allora ad un concetto cardine, nonché ritengo, almeno in parte, universalmente condiviso. L’Arte è Linguaggio: non uno tra tanti, ma linguaggio stesso. Il suo rapporto con le canoniche e per alcuni superate sette espressioni: Architettura, Musica, Pittura, Scultura, Poesia, Danza e Cinema (di suddivisioni ne sono sorte a bizzeffe) è lo stesso che intercorre tra la Parola ed i vari idiomi esistenti. Dando un rapido sguardo alle sette arti sopra citate, ci rendiamo conto di come l’ultima, il Cinema, contempli un po’ tutte le prime sei e che, pur essendo in qualche modo derivativa della fotografia, quest’ultima non figura in tale elenco. Con l’approssimarsi dell’Età Moderna, gli studiosi hanno cominciato a sbizzarrirsi in tal senso, rendendo il concetto di Arte, nonché le categorie ad essa collegate, sconsideratamente più elastiche. Il risultato, rispetto ad un’epoca fortemente selettiva, o meglio dire chiarificatrice circa ogni campo del Sapere (come il Medioevo e la stessa prima parte dell’Età Moderna, entrambi, suppongo, per effetto di una ineludibile radice classicista), fu quello di generare solo confusione.
Ciò a cui assistiamo oggi non è che il risultato di un più o meno lungo decorso, per cui l’abbandono di un serio e sano discorso sull’Arte ci ha condotto alle attuali derive. L’Arte, oggi, è per lo più sensazione, termine che funge da comune denominatore ad ogni tipo di pseudo-arte, che sia performativa, visiva, plastica e chi più ne ha più ne metta. La Contemporaneità ha preferito seguire la via del caos, delegando a quest’ultimo il compito di vomitare “Arte”. Reciso ogni collegamento con l’Arte di sempre, non si è più stati in grado di perseguire un reale progresso, perché a ciò che si rigenera ed autogenera in continuazione non può applicarsi alcuna evoluzione. Potremmo dire che buona parte di ciò che l’Arte Contemporanea ci propina da almeno un secolo a questa parte sia nel migliore dei casi artistico, non Arte.
Qui già sento gli esperti, coloro ai quali non la si fa: «l’Arte non è per tutti, bisogna studiare!», «bisogna avere gusto, talento, e per certe cose non c’è preparazione o cultura che tenga!», e via discorrendo. È tipico il discorso di coloro che, credendo di aver scoperchiato il vaso di Pandora, si ergono a paladini del Giusto, senza però riuscire in alcun modo a parlare di Bello. In realtà, filosoficamente, già Aristotele prima e san Tommaso d’Aquino poi, rilevano che Bellezza, Giustizia e Verità sono praticamente sinonimi; caduto uno cadono tutti. Operando un salto da campioni olimpici, diremmo che l’Arte non bella, ergo non vera, è menzogna, dunque non è Arte. Ho rotto le righe, per di più deliberatamente, lo so. Ma capite bene che da alcuni secoli a questa parte sono venuti meno i presupposti per poter inequivocabilmente stabilire cosa sia Arte e cosa no, è evidente che un medium come il Videogioco non può che fare immane fatica per trovare una propria collocazione.

DE BIOSHOCK «INFINITO»
In qualche modo, so che questa leggera ed incompleta digressione sia servita ad inquadrare quanto sto per scrivere. In toni meno accusatori, se vogliamo, ma senz’altro più pratici. Entriamo direttamente nel merito del discorso inerente a BioShock Infinite. Il sottoscritto ha trovato l’ultima fatica di Irrational Games un piccolo gioiello, che ha portato a termine in maniera oserei dire compulsiva – non mi davo al pad per cinque ore di fila da almeno tre anni. Questo per sottolineare, per quel che vale, quanto mi senta già legato a questo gioco. Eppure BioShock Infinite, ironia della sorte, è il gioco che più di ogni altro smentisce chiunque voglia a tutti i costi elevare il mezzo al grado di Arte.
Una cosa alla volta. Quando accennavo al fatto che l’Arte fosse tale anche e soprattuto perché «in grado di camminare con e sulle proprie gambe», intendevo in parte sostenere quanto segue: un’Arte, per dirsi tale, deve contemplare in sé stessa una peculiarità che più di tutte la distingue e dunque la qualifica. Per farla breve, si è solitamente concordi, sino a prova contraria, che l’unica componente che, più di qualunque altra, tenda a rendere il medium videoludico autonomo rispetto a tutti gli altri sia proprio l’interattività. Non l’interazione che è empatia, oppure catarsi. Nossignore, parlo proprio di quel processo per cui degli elementi su uno schermo reagiscono in maniera più o meno fedele a dei comandi che impartisce il soggetto giocante, fruitore principale ma non unico del sostanziarsi di tale mezzo – sono un fermo assertore dell’innegabile valore dell’attendere ad un qualsiasi videogioco in qualità di semplice spettatore; tesi che già essa stessa vanificherebbe la componente pregnante di questo mezzo, ossia proprio l’interattività: insomma, un videogioco può benissimo essere anche solo guardato, per quanto si tratti di un’esperienza di tipo diverso, ma non a tutti i costi inferiore gerarchicamente rispetto a quella classica.
Applichiamo quanto appena evidenziato ad Infinite. In cosa consiste il gameplay di questo gioco? Niente di più usuale negli ultimi otto anni: sparare, sparare, sparare. Le fasi di gioco dell’ultimo BioShock poggiano sul più classico degli schemi da tempo vigenti, riassumibile in tre momenti:
entri in un’area – affronti una o più orde di nemici – assisti ad un filmato/dialogo
E così fino alla fine, in un reiterato ripetersi di questi tre passaggi essenziali. Andando più a fondo in relazione a questa specifica componente, potremmo pure aggiungere che in tal senso non vi è alcuno slancio; il sistema di combattimento non risente pressoché di alcuna modifica, riproponendo dei modelli ampiamente sdoganati, tali da far sembrare (non a torto) già il primo BioShock un titolo sostanzialmente superiore in tal senso. L’uso dei Vigor, l’equivalente dei Plasmidi, assume un suo ruolo, seppure si abbia l’impressione che nelle passate iterazioni fosse ancora più indispensabile alternare pallottole e poteri speciali. Quanto all’uso delle armi, ci sono titoli che offrono un impatto obiettivamente più intenso, facendoci avvertire con più profondità la differenza tra l’impugnarne una anziché un’altra. C’è, è vero, l’integrazione delle Skyline, ossia quei binari ai quali ci si appende per poi muoversi da un punto ad un altro, offrendo effettivamente delle soluzioni alternative; tanto che non poche abilità si concentrano esattamente su tale meccanica. Ma questo è davvero tutto.

OLTRE IL GAMEPLAY
In un tutt’altro che corposo capoverso direi che abbiamo risolto in maniera alquanto veritiera la natura interattiva di Infinite. Ciò che davvero ha fatto accapponare la pelle a molti, però, è innegabilmente tutt’altro. Due, in tal senso, gli elementi pregnanti: narrazione e level-design. Nel primo caso, lì troviamo il vero fulcro del progetto, in quel suo offrire un modo effettivamente diverso, in parte inedito, di strutturare una storia, peraltro avvincente. Nel secondo caso, trattasi praticamente dell’aspetto che più trae in inganno di solito quando si parla di Arte ed artisticità, perché si tende a dedurre che un comparto artistico notevole significhi di conseguenza Arte. Come abbiamo in parte illustrato sopra, sappiamo che non è così. L’art-design di BioShock Infinite è notevole ed ispirato come pochi, davvero pochi. Alla migliore composizione spaziale del primo BioShock, oppone una magnificenza di colori ed elementi innovativi non solo per la serie ma per il settore tutto, senza se e senza ma. Eppure non posso fare a meno di ammettere di aver avvertito Rapture in maniera decisamente più viva. Anche il primo BioShock si atteggiava ad un mezzo open-world pur, di fatto, non essendolo; eppure gli spazi erano congegnati in maniera talmente abile che avvertivi il senso di appartenenza a quel posto, sentivi di esserci non semplicemente di assistervi. In Columbia, purtroppo, si ha come l’impressione di osservare da fuori una stupefacente vetrina, senza però avere modo di entrare in quel negozio. È un po’ la medesima sensazione sperimentata in L.A. Noire, solo che in quest’ultimo caso lo spreco di un lavoro apparentemente così accattivante, come la creazione della Los Angeles degli anni ’40, era ampiamente più palese.
Questo senso di ingabbiamento, oltre ad essere paradossale, è forse spiegabile proprio attraverso un paradosso. Per l’intera durata del primo BioShock, noi Rapture la vediamo e viviamo dal di dentro, senza mai avere un’idea concreata di come sia “da fuori”. Sì, ci vengono offerte alcune panoramiche, ma nessuna di queste risulta non solo esaustiva ma anche solo esplicita circa la conformazione grossomodo totale di quella micidiale utopia che è una metropoli sott’acqua. Di Columbia, invece, in più occasioni ci viene offerta una cartografia abbastanza netta. Non dico di ricordare per filo e per segno dove si trova una zona della città piuttosto che un’altra, ma proprio in relazione alla collocazione delle due città (Rapture nell’Oceano, Columbia in cielo) il paradosso di cui sopra sprigiona tutta la sua potenza: in quella opprimente gabbia che è Rapture non riesci mai, o quasi, a realizzare il suo inizio né la sua fine. Ciò ti consente di esperire in maniera di gran lunga più efficace i vari spazi, che vivi con estrema soggezione in lungo e in largo. In altre parole, non un centimetro di quella location viene sprecato, proprio perché delimitato all’infinito.
Nella nuova ambientazione, all’opposto, emerge molto più nitidamente la finitezza del luogo, e ciò si ricava esattamente da questa mancata delimitazione; siamo in cielo, sarebbe perciò lecito credere che, almeno quando ci si muove per le Skyline, si riesca a percepire un pronunciato senso di libertà proprio in virtù dei contorni, incerti perché essenzialmente costituiti dal cielo. Venendo di conseguenza meno, tra l’altro, quell’effetto velatamente orrorifico del primo capitolo della saga; perché, oramai è lezione che conoscono tutti, l’horror si crea anzitutto lavorando con e sullo spazio. Resta da capire se tale tono fosse voluto o meno, ma in linea di massima ritengo che non sia così.
Per chiudere questo nostro passaggio, diremmo che la sconfinata ampiezza dei cieli di Columbia viene vanificata dai troppi spazi aperti all’interno delle varie aree; aperti sì, ma stretti, angusti. Diversamente da Rapture, dove l’effetto prigione è la base su cui poggia l’intera struttura spaziale, tale da consentirci di ampliarne gli spazi mediante l’integrazione di un ineffabile mistero che manca del tutto nel terzo capitolo della saga. Guardare attraverso le spesse vetrate dell’angosciante Rapture ci faceva immaginare di tutto e di più: tanto che, quando alla fine emergiamo, è bene che non ci venga mostrato quasi nulla, perché diversamente gli sviluppatori avrebbero vanificato il pregevole lavoro condotto sino a quel punto. Una volta che emergi sei libero, questo basta e avanza.
Altra incancellabile componente di assoluta rilevanza giace nella narrazione. Non nella trama in sé, ma in come viene portata avanti. In tal senso mi auguro che molti sviluppatori prendano nota: mescolate gli elementi quanto più vi sarà possibile, senza però inglobare quella lezione dell’Arte Contemporanea secondo cui gli elementi vadano mischiati fino all’estremo, fino a che non si riesca più riconoscerli, né singolarmente né nell’insieme. Se c’è una insegnamento che traiamo dal Cinema è che in contesti simili, dove è l’immagine e non il testo scritto a farla da padrone, non importa tanto la storia in sé, quanto il modo in cui viene raccontata. Da questo punto di vista s’impone con prepotenza l’indole del Ken Levine sceneggiatore, quello che, fino a qualche tempo fa, ammise candidamente che avrebbe sacrificato più che volentieri tutto per la trama (dove «tutto» sta per gameplay… stiamo sempre parlando di videogiochi).
Al tempo il sottoscritto inveì silenziosamente contro mister Levine, tacciandolo di eresia; col tempo ho cominciato a capire. Ken fa argutamente leva su istinti che la comunità giocante fatica ad ammettere, anzitutto a sé stessa, sebbene gran parte di coloro che giocano assiduamente sarebbe perfettamente in grado di spiegare tutto ciò. In quella bramosia di legittimazione del mezzo che contraddistingue moltissimi tra i più abituali fruitori di videogames, si cela una necessità repressa: quella di sentirsi all’altezza di avidi divoratori di libri, cinefili, musicofili e chi per loro. L’aspetto interessante è che non di rado un giocatore rientri anche in almeno una di queste categorie. Come mai, allora, quest’ambizione implicita?
Beh, è un’ipotesi, quindi la si prenda come tale al momento. Torniamo all’arte della sensazione, definizione che funge da comune denominatore a quasi tutta l’Arte Contemporanea: è innegabile che il Videogioco susciti qualcosa, e che tale quid sia anche parecchio forte. In ragione di questa ineludibile virtù del mezzo, in tanti ritengono che ciò basti ad elevarlo. E a cosa si aggrappano, innanzitutto? Ovvio, ai contenuti, alla scontata capacità che ha il Videogioco di illustrare storie mature. È tutto lì. La comunità giocante – parte di essa – si bagna al cospetto di una storia intrigante, saputa raccontare con un certo piglio. Improvvisamente, pare che il settore tutto operi un salto, squarciando quel velo che lo separa dall’Arte. Ma ahimè non è così semplice.

ARTE PER L’ARTE OPPURE ARTE?
Ci siamo appena soffermati su due aspetti pregnanti di Infinite, che ne fanno la sua fortuna, cioè la narrazione e l’art-design. Vogliamo dare un nome più specifico a queste due categorie? Altroché! E lo facciamo servendoci delle fonti a cui sono entrambe riconducibili. La prima attiene senz’altro alla Poesia/Letteratura, che non sono esattamente la stessa cosa, ma che prima e più di ogni altro mezzo espressivo, sin dai tempi della tradizione orale, hanno veicolato storie, avvenimenti, episodi, vicende, e nei modi più disparati. La seconda, invece, riguarda facile l’Architettura e la Pittura, ossia coloro alle quali è deputata l’armoniosa e funzionale gestione e/o raffigurazione dello spazio, quale che esso sia.
Capite? Ci stiamo avvicinando pericolosamente al punto. Infinite non brilla per una sola delle componenti intrinsecamente ancorate al mezzo attraverso cui si manifesta; questo perché, adesso possiamo brutalmente dirlo, non ve ne sono ancora. Esatto, al Videogioco mancano ancora quelle gambe su cui può tranquillamente reggersi senza l’ausilio di nessun altro. Badate bene, è un po’ come quando da poco più che neonati i vostri genitori, o chi per loro, vi tenevano per le mani mentre cercavano di farvi camminare. E voi, con quelle gambette gonfie ma prive di muscolatura alcuna, che inciampavate soli perché, semplicemente, non vi era ancora chiaro cosa significasse l’espressione “un passo dopo l’altro”. Poi siete cresciuti, e la medesima cosa è avvenuta quando avete dovuto imparare a nuotare, ad andare in bici e via discorrendo. Ma non è che dopo avete messo da parte la “lezione” appresa da chi vi ha insegnato a camminare, cominciando a farlo sulle mani anziché coi piedi.
Il Cinema ci ha messo un po’ a capire che tale mezzo potesse veicolare anche storie; inizialmente ci fu anche parecchia ritrosia a riguardo. A poco a poco venne fuori la lezione dei maestri russi, con Ėjzenštejn e Pudovkin su tutti che mostrarono una strada nuova, di lì a venire ma ancora sconosciuta a tutti: nasce il Montaggio, non il semplice avvicendarsi di sequenze, bensì la costruzione di senso mediante l’accurata disposizione di brevi o lunghe sequenze. Il Cinema diventa Arte, perché, pur ancora servendosi di tutte le Arti che l’hanno preceduto, la Settima comincia a stilare uno statuto proprio, capace di porre in essere qualcosa che oggettivamente manca a tutte le altre. Col tempo tale statuto si va chiaramente arricchendo, anche contraddicendosi talvolta, ma orami il danno è fatto. Vi domando, dunque: esiste qualcosa di simile nel Videogioco? Posto che l’interattività, che ad oggi rimane l’unica, vera peculiarità del mezzo, sia necessaria ma non sufficiente in tal senso, cos’altro possiamo aggiungere a riguardo? In tutta onestà, mi pare nulla.

VERSO DOVE STA ANDANDO IL VIDEOGIOCO
Troppa crudeltà, me ne rendo conto. Ma a cos’altro ci si può appellare quando uno dei titoli più rappresentativi di questo settore brilla di un fulgido splendore solo ed esclusivamente per virtù esterne al medium videoludico? Sia ben chiaro, sono un promotore della teoria olistica, per cui l’insieme vale sempre più della somma delle proprie parti, ma in questo caso non possiamo risolvere tutto mediante il ricorso a tale scappatoia. Il Videogioco non ha senz’altro bisogno, né deve permettersi, di rinnegare le Arti che l’hanno preceduto. Ma deve andare oltre, e deve farlo al più presto! Proprio questo suo temporeggiare lo sta portando a “scomparire”, sepolto tra le macerie di social e connettività varie che vanno impilandosi uno sopra l’altro. Anche qui, badate bene, è un po’ il medesimo passaggio epocale che sta attraversando il Cinema col graduale ridimensionamento della sala, vero tempio di quest’Arte-Religione. Ma sarebbe troppo facile dare ogni colpa ad Internet, al fatto che oramai quest’ultimo abbia preso il sopravvento nelle nostre vite: trattasi semplicemente del mezzo divenuto fine, il che rappresenta senz’altro una potenziale tragedia, ma che ai fini del nostro discorso rileva poco.
Ecco perché fatico a comprendere gli atteggiamenti apatici di tanti, troppi, nei riguardi di uno come David Cage. Possibile che vi basti prendere atto del fatto che la storia di Heavy Rain non sia tutto ‘sto capolavoro per mandare al macero l’intero operato di questo capace game designer? Sì è vero, talvolta pare anche troppo affezionato all’idea di racconto, ma non è per forza detto che lui abbia torto e noi ragione. Ad oggi i tentativi maggiormente pioneristici, e su larga scala, appartengono al suo studio, i Quantic Dream. Potrà anche non piacervi giocare così, ma non ci conviene fermarci a cosa ci piace e cosa no. Ci rendiamo conto che, a prescindere dalla reale abilità di Cage, quest’ultimo è l’unico che si sta consumando verso la direzione che abbiamo auspicato sopra, ossia quella di offrire a questo mezzo un’identità propria, specifica? Che anche lui (ma non è il solo), tiene per le braccia quell’infante che è il Videogioco nel tentativo di insegnargli a camminare con le proprie gambe?
A Fumito Ueda “bastò” inserire un secondo personaggio, trascendendo il concetto di singolo e multigiocatore: partorì ICO, che al di là di tutta la Poesia su cui a tanti piace soffermarsi, spicca per questa fulminante intuizione di affidarci questo “peso morto” che prende il nome di Yorda. E forse mai come allora abbiamo amato così tanto il doverci sacrificare per qualcun altro in un videogioco, spasimando per il nostro limite più evidente. Provate a replicare qualcosa di simile in qualunque altro contesto che non sia quello squisitamente videoludico!
I protagonisti di questo settore, ma in fondo noi tutti, devono/dobbiamo metterci/vi in testa che senza sperimentazione il videogioco non va da nessuna parte. E non parlo di iniziative come quelle relative al motion control o tutti gli accattivanti ammennicoli di imminente generazione. Questa altro non è che sperimentazione tecnologica applicata al mezzo, che non dispiace (ci mancherebbe), ma che ai fini di quanto fino ad ora rilevato importa relativamente. Qui si tratta di speculare su uno o più linguaggi, inediti o rodati che siano. Paradossalmente ho l’impressione che ciò che più abbisogni a questo medium non sia della stupefacente tecnologia, bensì di un vero e proprio linguaggio che lo contraddistingua massimamente. Tale linguaggio non può prescindere da una certa univocità, per cui potremo dire che, a determinate condizioni, un’opera è o meno un videogioco. Come nel Cinema, poi, si potrà liberamente spaziare, ma fino ad allora resta la libertà senza la regola; che quindi non è più libertà, bensì caos. Da tutto ciò non può in alcun caso avere origine qualcosa di organico, sebbene il videogioco abbia disperatamente bisogno di organicità.
Non lo dico io, lo dicono le società protagoniste nel settore: se abbiamo bisogno di tutte queste trovate social o pseudo-tali, vuol dire che il “vecchio” linguaggio non solo cominci a star stretto, ma che, peggio, non si presti nemmeno (secondo loro) ad una naturale evoluzione. Sony e Microsoft ci mostrano i loro ultimi ritrovati come l’ovvia evoluzione di un settore mantenuto artificialmente in vita da esigenze fittizie, deliberatamente create a tavolino. Sembra quasi che se il videogioco non si adeguasse ai fenomeni più in voga della nostra epoca rischierebbe l’annientamento. Ma una vera Arte, per essere tale, deve anche e soprattutto scardinare certe logiche, imponendo essa stessa degli “standard”, o meglio, dei modelli (pattern, all’anglofona) tali da influenzare lei tutto il resto.

UN SENTIERO POSSIBILE?
Ecco, in particolar modo dall’impatto sulla civiltà all’interno della quale si muove si giudica il rango di un determinato medium. Non importa che il Videogioco venga pluricitato, al Cinema come nella Musica o nella Letteratura: sono vittorie di Pirro, sterili riconoscimenti che non legittimano alcunché se non l’infanzia di un mezzo capace di intrattenere come le carte da gioco; sacrificando dunque dei presupposti che ci inducono a pretendere tutt’altro. Forse il problema sta essenzialmente lì, ossia nel non voler riconoscere l’assoluta rilevanza del gioco, così come lo intendono gli inglesi, ossia «play». Creazione ed interpretazione di disparati mondi impossibili ma non impensabili, che ci aiutano a prendere coscienza del fatto che non tutto ciò che vediamo ci basta, né tutto si esaurisce lì. Giocare viene percepito come qualcosa di essenzialmente accessorio, che giusto in un periodo di radicale spensieratezza, quale è l’infanzia, ci si può permettere. Io dico, e oso, che metà dei mali che affliggono oggi l’uomo non esisterebbero nemmeno se gli fosse concesso di giocare in maniera sana, ma soprattutto spontanea. E fate attenzione, perché il concetto di gioco è di gran lunga più elastico di quello che manifesta all’impatto; ampiezza e profondità che gli vengono garantite da leggi ben precise, che, lungi dal vietare, ordinano. Il Videogioco ha saggiamente e furbescamente fatto proprie alcune di queste forme, trasponendole ed adattandole al contesto che più gli si confà. Fare (non essere) i genitori non è po’ come un enorme RPG?
È esattamente questo che il Videogioco, divenendo Arte, può e deve contribuire a superare. È su questo campo che si gioca (!) il suo e forse, in qualche misura, pure il nostro destino: nel mostrare all’uomo che una delle sue peculiarità, in quanto opera d’Arte, risiede proprio nella sua facoltà di giocare. Niente a che vedere con il simpatico ma fuorviante Ludo ergo Sum, perché anche gli animali, in natura, giocano. Noi, però, a differenza di quest’ultimi, possiamo anche creare; possibilità preclusa a qualunque altra specie esistente o defunta sulla faccia della Terra. Al bimbo vengono consegnate delle coloratissime costruzioni: lui le scruta, le prende tra le mani, ci pensa e… costruisce il suo fortino, la sua abbazia, la sua casa, il suo mondo. Per quant’altro varrebbe la pena vivere?